Storie di profughi e di immigrati nei racconti dello scrittore francese premio Nobel per la letteratura nel 2008
Cosmopolita e grande viaggiatore, Jean-Marie Gustave Le Clézio ha al suo attivo una quarantina di opere tra romanzi, novelle e saggi, in cui l’impegno sociale a favore delle politiche di integrazione dei profughi e degli immigrati va di pari passo con le descrizioni suggestive di spazi esotici, come quelli mauriziano e africano.
Le affermazioni consegnate il 1° aprile del 2018 alle pagine del Journal du Dimanche ne sono una testimonianza: «La chiusura o l’apertura delle frontiere rimane un problema» ha spiegato «ma una volta che qualcuno giunge in Francia, è inaccettabile trattarlo male […]. Sin dall’infanzia sono stato tacciato di essere un ingenuo. Ma non lo sono. Vedo le cose semplicemente in modo diverso, preferisco gli artisti ai politici […]. Le mie origini bretoni e mauriziane mi spingono a privilegiare la condivisione; dunque, se fosse necessario, redigerei un atto d’accusa contro la cattiva accoglienza inflitta agli immigrati». Dopo essersi detto scandalizzato per il modo in cui questi verrebbero trattati nel suo Paese, si è rivolto, quindi, al presidente Emmanuel Macron invitandolo a migliorare le direttive applicate dal ministro dell’Interno Gérard Collomb. Il suo «Améliorez-vous, monsieur Macron!» non stupisce i lettori, poiché egli si mostra coerente con alcune delle tematiche affrontate in opere come la novella Le Passeur, contenuta nella raccolta La Ronde et autres faits divers (1982), il romanzo Étoile errante e L’enfant et la guerre, pubblicato con Chanson bretonne il 12 marzo del 2020.
Il primo racconto prende le mosse dal viaggio di Miloz, un immigrato dell’Est che raggiunge la Francia di nascosto, insieme a un manipolo di uomini di varia nazionalità, «Greci, Turchi, Egiziani, Iugoslavi, Tunisini», che come lui vivono nell’angoscia dell’anonimato. La descrizione dell’attraversamento illegale della frontiera, la presenza di personaggi negativi, come il trafficante Tartamella, e le condizioni di vita ai limiti della normalità producono una tensione narrativa che restituisce la condizione dei clandestini, presentati come un’«infinita umanità» schiacciata dalle ingiustizie e dall’indifferenza generale. È quando Miloz deciderà di fuggire che emergerà, però, l’originalità dell’autore e il vero significato che egli ha voluto attribuire alla propria narrazione.
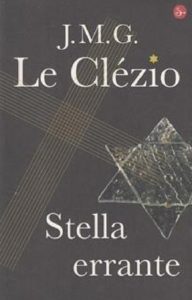 Deluso nelle proprie aspettative, l’uomo intraprenderà un nuovo viaggio a ritroso che lo riporterà a casa, dai suoi affetti e dalla donna amata, Lena, lontano dagli sfruttatori che lo hanno privato della sua identità. Altrettanto significativo è il romanzo Étoile errante, pubblicato in Italia dal Saggiatore con il titolo Stella errante (2008), in cui le due protagoniste in fuga, Esther e Nejma, consentono all’autore di puntare i riflettori sul conflitto israelo-palestinese e sull’esodo di migliaia di profughi che ha generato. È l’estate del 1943 quando l’ebrea Esther, che i genitori chiamano con il nome di copertura Hélène per proteggerla dalla persecuzione nazista, raggiunge l’Italia, dopo una estenuante marcia forzata attraverso le Alpi. Ad attendere i migranti vi è la Sette Fratelli, la nave che li porterà Israele. Le peripezie narrate trascendono, in realtà, l’esperienza personale vissuta dalla ragazza, poiché sono riconducibili a quelle di tutti gli esuli, senza alcuna distinzione di etnia o di credo religioso. Non è un caso, infatti, se Esther, in cammino verso la sua nuova casa, incrocerà un’altra adolescente, Nejma, su una carovana di palestinesi, costretti a loro volta a lasciare la propria abitazione per far posto agli ultimi arrivati. Uno sguardo e lo scambio innocente di un quaderno tra le due ragazze saranno sufficienti a unire i destini di due popoli accumunati dalle stesse ingiustizie subite.
Deluso nelle proprie aspettative, l’uomo intraprenderà un nuovo viaggio a ritroso che lo riporterà a casa, dai suoi affetti e dalla donna amata, Lena, lontano dagli sfruttatori che lo hanno privato della sua identità. Altrettanto significativo è il romanzo Étoile errante, pubblicato in Italia dal Saggiatore con il titolo Stella errante (2008), in cui le due protagoniste in fuga, Esther e Nejma, consentono all’autore di puntare i riflettori sul conflitto israelo-palestinese e sull’esodo di migliaia di profughi che ha generato. È l’estate del 1943 quando l’ebrea Esther, che i genitori chiamano con il nome di copertura Hélène per proteggerla dalla persecuzione nazista, raggiunge l’Italia, dopo una estenuante marcia forzata attraverso le Alpi. Ad attendere i migranti vi è la Sette Fratelli, la nave che li porterà Israele. Le peripezie narrate trascendono, in realtà, l’esperienza personale vissuta dalla ragazza, poiché sono riconducibili a quelle di tutti gli esuli, senza alcuna distinzione di etnia o di credo religioso. Non è un caso, infatti, se Esther, in cammino verso la sua nuova casa, incrocerà un’altra adolescente, Nejma, su una carovana di palestinesi, costretti a loro volta a lasciare la propria abitazione per far posto agli ultimi arrivati. Uno sguardo e lo scambio innocente di un quaderno tra le due ragazze saranno sufficienti a unire i destini di due popoli accumunati dalle stesse ingiustizie subite.
Senza mai cedere alla tentazione di parteggiare per gli uni o per gli altri, Le Clézio ci trascina, così, nella seconda parte del libro, nel campo profughi di Nour Champ, che ci viene descritto attraverso lo sguardo di Nejma: «Il campo di Nour Champ – ci racconta – è senza dubbio alla fine del mondo […]. I giorni si sono accumulati, simili a una polvere sottile di cui non si conosce la provenienza […]. L’acqua era diventata così rara che non ci si poteva più lavare, né lavare i propri abiti. I vestiti dei bambini erano sporchi di escrementi, di pezzi di cibo, di terra e gli indumenti femminili erano diventati rigidi di sporcizia, simili alla corteccia».
 Condannate all’esilio, le due protagoniste assurgono a simbolo della condizione dei loro rispettivi popoli, alla costante ricerca di una identità e di una patria. Stella errante è Esther poiché è questo il significato del suo nome e perché la stella di Davide è il simbolo della civiltà e della religiosità ebraica; Stella errante è anche Nejma che, in arabo, racchiude uguale accezione. La tematica dell’esilio ritorna protagonista nella sua opera più recente, L’enfant et la guerre. Il contesto è la Seconda guerra mondiale e quella narrata è l’esperienza vissuta dal medesimo autore. Nato il 13 aprile del 1940, Le Clézio racconta di aver trascorso i primi cinque anni della sua vita all’interno della «macchina cieca e feroce» del conflitto, guidata da adulti ridotti all’anonimato dalle stesse uniformi che indossano. La fuga da Nizza, le lunghe giornate trascorse in un rifugio al riparo dalla violenza, le sporadiche uscite mattutine alla ricerca «di cibo», unica distrazione alla monotonia quotidiana, vengono descritti alla fine della narrazione come ricordi indelebili: «Ancor più dei pericoli, ciò che mi ha nutrito […], è il sentimento di estraneità» ci confida l’autore. «Come se la guerra avesse scavato per sempre una fossa tra il prima e il dopo».
Condannate all’esilio, le due protagoniste assurgono a simbolo della condizione dei loro rispettivi popoli, alla costante ricerca di una identità e di una patria. Stella errante è Esther poiché è questo il significato del suo nome e perché la stella di Davide è il simbolo della civiltà e della religiosità ebraica; Stella errante è anche Nejma che, in arabo, racchiude uguale accezione. La tematica dell’esilio ritorna protagonista nella sua opera più recente, L’enfant et la guerre. Il contesto è la Seconda guerra mondiale e quella narrata è l’esperienza vissuta dal medesimo autore. Nato il 13 aprile del 1940, Le Clézio racconta di aver trascorso i primi cinque anni della sua vita all’interno della «macchina cieca e feroce» del conflitto, guidata da adulti ridotti all’anonimato dalle stesse uniformi che indossano. La fuga da Nizza, le lunghe giornate trascorse in un rifugio al riparo dalla violenza, le sporadiche uscite mattutine alla ricerca «di cibo», unica distrazione alla monotonia quotidiana, vengono descritti alla fine della narrazione come ricordi indelebili: «Ancor più dei pericoli, ciò che mi ha nutrito […], è il sentimento di estraneità» ci confida l’autore. «Come se la guerra avesse scavato per sempre una fossa tra il prima e il dopo».
Scolpita nella memoria è anche la figura di Mario, il quindicenne italiano che Le Clézio aveva già rievocato nel romanzo Il ritornello della fame (Rizzoli, 2009). Questo «eroe della Resistenza» – così ama definirlo – ci viene presentato nella sua ambiguità di adolescente segnato dalla brutalità del suo tempo: la semplicità dei suoi gesti giovanili e scherzosi, come schizzare l’acqua del fiume ai suoi compagni, cede il posto al “soldato” che muore trasportando una bomba che avrebbe dovuto rallentare l’avanzata dei tedeschi.
 Di Mario non rimarrà altro che una ciocca di capelli rossi, l’unico indizio che consentirà di riconoscere il suo corpo martoriato: «È morto trasportando una bomba […]. È senza dubbio questa parte della storia che mi turba. Che mi fa comprendere che la guerra uccide i bambini. Che non si può essere veramente un bambino quando si viene alla luce mentre infuria la guerra». Asciutti e vibranti i suoi ricordi si leggono in modo sorprendente per l’accostamento che egli opera tra la propria esperienza, vissuta nella lontana estate del 1943, e quella attuale, che continua a coinvolgere molti minorenni e che impariamo a conoscere attraverso i giornali e la televisione: «Se la bomba canadese che mi ha spaccato i timpani ha causato tutti questi danni, quale ricordo – si chiede – conserveranno di queste bombe moderne, così pesanti, così efficaci, queste bombe concepite per perforare il cemento e raggiungere il nemico finanche nello scantinato?». In tutti loro, figli di quanti sono in fuga dai Paesi in guerra come l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria, la Somalia e il Sudan, che vengono guardati con diffidenza e non ricevono la giusta accoglienza, egli ritrova il suo volto smunto, fissato per sempre in alcune foto sbiadite, e l’atteggiamento collerico di suo fratello, segnato anch’egli dalla violenza. Al pari di quei bambini, ricorda, «portiamo degli abiti rattoppati, proprio come loro abbiamo un’espressione sorniona sui nostri volti. Il segno che lascia la paura, come loro abbiamo bisogno di vendicarci su qualcosa, di colpire, di gridare, di mordere».
Di Mario non rimarrà altro che una ciocca di capelli rossi, l’unico indizio che consentirà di riconoscere il suo corpo martoriato: «È morto trasportando una bomba […]. È senza dubbio questa parte della storia che mi turba. Che mi fa comprendere che la guerra uccide i bambini. Che non si può essere veramente un bambino quando si viene alla luce mentre infuria la guerra». Asciutti e vibranti i suoi ricordi si leggono in modo sorprendente per l’accostamento che egli opera tra la propria esperienza, vissuta nella lontana estate del 1943, e quella attuale, che continua a coinvolgere molti minorenni e che impariamo a conoscere attraverso i giornali e la televisione: «Se la bomba canadese che mi ha spaccato i timpani ha causato tutti questi danni, quale ricordo – si chiede – conserveranno di queste bombe moderne, così pesanti, così efficaci, queste bombe concepite per perforare il cemento e raggiungere il nemico finanche nello scantinato?». In tutti loro, figli di quanti sono in fuga dai Paesi in guerra come l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria, la Somalia e il Sudan, che vengono guardati con diffidenza e non ricevono la giusta accoglienza, egli ritrova il suo volto smunto, fissato per sempre in alcune foto sbiadite, e l’atteggiamento collerico di suo fratello, segnato anch’egli dalla violenza. Al pari di quei bambini, ricorda, «portiamo degli abiti rattoppati, proprio come loro abbiamo un’espressione sorniona sui nostri volti. Il segno che lascia la paura, come loro abbiamo bisogno di vendicarci su qualcosa, di colpire, di gridare, di mordere».
Marilena Genovese
(LucidaMente 3000, anno XVI, n. 185, maggio 2021)

















