Nel saggio “La felicità negata” (Einaudi) Domenico De Masi, riprendendo le idee di Keynes e della Scuola di Francoforte, critica le tesi della Scuola di Vienna e propone il “salario universale” come mezzo più efficace per ridurre la povertà
La società di consulenza tecnologica Capgemini ha calcolato che nel 2021 sono aumentati gli individui con un patrimonio accertato di almeno un milione di dollari (22,5 milioni nel mondo, 322 mila in Italia). I super ricchi si sono spartiti complessivamente circa 86 mila miliardi di dollari, una cifra superiore al Pil mondiale, stimato in 84,7 mila miliardi di dollari. La vera élite mondiale, tuttavia, è costituita da appena alcune migliaia di “paperoni”, che in media hanno guadagnato 133 milioni di dollari a testa (vedi Pietro Saccò, Disuguaglianze. Il 2021 è stato un altro ottimo anno per i super ricchi, in www.avvenire.it).
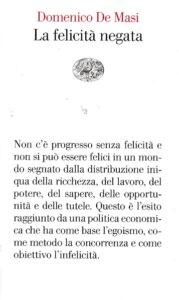 La grande maggioranza dell’umanità annaspa invece nella miseria: infatti, secondo i dati forniti dal sito di statistica Our World in Data, l’85% della gente vive con meno di 30 dollari al giorno, due terzi vivono con meno di 10 dollari al giorno e una persona su dieci con meno di 2 dollari al giorno (vedi Max Roser – Esteban Ortiz-Ospina, Global Extreme Poverty in https://ourworldindata.org; Lorenzo Ruffino, Com’è distribuita la povertà assoluta nel mondo?, in www.youtrend.it). Come si può vivere felici in un mondo nel quale da oltre un trentennio prosperano la disuguaglianza sociale e la povertà, alle quali si sono recentemente aggiunte anche varie catastrofi (crisi energetica, emergenza climatica, guerra in Ucraina, pandemia, ecc.)? A questo arduo quesito ha provato a rispondere il sociologo Domenico De Masi nel saggio La felicità negata (Einaudi, pp. 138, € 12,00), dove ha messo a confronto due tra le maggiori correnti di pensiero del Novecento: la Scuola di Vienna e la Scuola di Francoforte. La prima fu fondata nel 1871 dall’economista viennese Carl Menger, che raccolse attorno a sé un folto gruppo di studiosi, tra i quali spiccavano Eugen von Böhm–Bawerk, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Friedrich von Wieser (alla scuola aderì anche il giovane Joseph Schumpeter, che, però, in seguito se ne distaccò). Si trattava di colti rampolli della nobiltà austriaca, vivamente interessati a «concentrare quante più risorse e potere nelle mani dell’élite dominante, facendo appello all’individuo e riducendo al minimo il ruolo dello Stato».
La grande maggioranza dell’umanità annaspa invece nella miseria: infatti, secondo i dati forniti dal sito di statistica Our World in Data, l’85% della gente vive con meno di 30 dollari al giorno, due terzi vivono con meno di 10 dollari al giorno e una persona su dieci con meno di 2 dollari al giorno (vedi Max Roser – Esteban Ortiz-Ospina, Global Extreme Poverty in https://ourworldindata.org; Lorenzo Ruffino, Com’è distribuita la povertà assoluta nel mondo?, in www.youtrend.it). Come si può vivere felici in un mondo nel quale da oltre un trentennio prosperano la disuguaglianza sociale e la povertà, alle quali si sono recentemente aggiunte anche varie catastrofi (crisi energetica, emergenza climatica, guerra in Ucraina, pandemia, ecc.)? A questo arduo quesito ha provato a rispondere il sociologo Domenico De Masi nel saggio La felicità negata (Einaudi, pp. 138, € 12,00), dove ha messo a confronto due tra le maggiori correnti di pensiero del Novecento: la Scuola di Vienna e la Scuola di Francoforte. La prima fu fondata nel 1871 dall’economista viennese Carl Menger, che raccolse attorno a sé un folto gruppo di studiosi, tra i quali spiccavano Eugen von Böhm–Bawerk, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Friedrich von Wieser (alla scuola aderì anche il giovane Joseph Schumpeter, che, però, in seguito se ne distaccò). Si trattava di colti rampolli della nobiltà austriaca, vivamente interessati a «concentrare quante più risorse e potere nelle mani dell’élite dominante, facendo appello all’individuo e riducendo al minimo il ruolo dello Stato».
La seconda fu istituita dai sociologhi tedeschi Friedrich Pollock e Felix Weil, che nel 1923 diedero vita all’Istituto per le ricerche sociali, affiliato all’Università Goethe di Francoforte. Di questa scuola sociologico-filosofica fecero parte illustri intellettuali del calibro di Theodor Adorno, Walter Benjamin, Eric Fromm, Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, i quali, pur avendo elaborato dottrine spesso differenti tra loro, furono accomunati da uno stesso intento politico, ossia garantire «una distribuzione della ricchezza e del potere più giusta nei confronti della massa subalterna, facendo appello alla collettività e confidando nell’intervento pubblico».
Gli intellettuali francofortesi furono tra i primi a denunciare le storture della società industriale. Fromm, nel saggio del 1941 Fuga dalla libertà (Mondadori), descrisse accuratamente la psicologia dell’uomo moderno, il quale sente su di sé il peso della libertà personale e tende al “conformismo gregario”, ovvero all’ubbidienza passiva verso i superiori e all’omologazione comportamentale, senza sforzarsi di pensare e agire autonomamente. Adorno e Horkheimer, nel volume del 1949 Dialettica dell’Illuminismo (Einaudi), denunciarono i mali che affliggevano sia il capitalismo occidentale che il comunismo sovietico: l’autoritarismo politico, il conformismo sociale, la reificazione delle relazioni umane, l’uso dell’“industria culturale” come mezzo di distrazione delle masse, la manipolazione della scienza e della tecnica. Marcuse riprese tali tematiche nello scritto del 1964 L’uomo a una dimensione (Einaudi), individuando negli intellettuali dissidenti, nei lavoratori precari e nei popoli del Terzo Mondo – ma non nella classe operaia, ormai integrata e incapace di ribellarsi – le forze antagoniste al “sistema” in grado di opporre il “Gran rifiuto”, cioè di vivere in modo libero e consapevole, autogestendo democraticamente le istituzioni pubbliche.
Tuttavia, i pensatori della Scuola di Francoforte – come ben evidenzia De Masi – «si tennero sempre lontani dalla politica militante» e le loro idee, pur influenzando i movimenti di contestazione degli anni Sessanta e Settanta, «non si sono mai trasformate in una consistente azione politica capace di cambiare la società»». Di ben altra portata fu l’influsso esercitato dai membri della Scuola di Vienna, che predicavano l’etica protestante del lavoro e furono «accortissimi nel conquistare posti di comando nelle banche, nelle imprese, nei ministeri», lottando a fondo contro un folto stuolo di avversari: «dall’ordoliberismo tedesco al keynesismo britannico, dal comunismo marxista alla pianificazione economica sovietica e al totalitarismo nazifascista».
Gli economisti austriaci si costituirono in un gruppo organizzato durante il Colloquio Walter Lippmann, una conferenza tenutasi a Parigi nell’agosto 1938. Costretti sulla difensiva dalla grave crisi economica del 1929 e dall’avvento in tante nazioni occidentali del “capitalismo di stato”, essi ripresero vigore dopo lo shock petrolifero del 1973 che provocò il fenomeno della “stagflazione” (stagnazione + inflazione), oggi purtroppo ritornato a turbare l’economia mondiale. A supportarli nella lotta contro lo “stato imprenditore” fu in particolare lo studioso statunitense Milton Friedman, principale esponente della Scuola di Chicago, all’interno della quale si formarono i Chicago boys, un gruppo di giovani economisti cileni destinati a sperimentare le tremende ricette neoliberiste durante la feroce dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990). Le idee di Friedman e della Scuola di Vienna vennero fatte proprie – dopo il 1989 – dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale, che dettarono i precetti della globalizzazione neoliberista (contenimento dei salari, deregulation, libera concorrenza, privatizzazione di beni e servizi pubblici, riduzione delle tasse per i ricchi, ecc.), gettando nella miseria e nell’infelicità gran parte della popolazione planetaria.
De Masi – nella parte conclusiva del libro – afferma che il diffuso malessere sociale potrà essere alleviato solo se si abbandonerà il modello neoliberista e si perseguirà il jobless growth (“sviluppo senza lavoro”), mettendo in pratica quanto preconizzato da John Maynard Keynes in tre conferenze tenute tra il 1928 e il 1930, in seguito pubblicate sotto forma di breve saggio dal titolo Possibilità economiche per i nostri nipoti (vedi J. M. Keynes, Economic Possibilities for Our Grandchildren, in https://link.springer.com; Che futuro ci sarà per i nostri nipoti?).
L’economista britannico era certo che la crescita costante dell’automazione avrebbe portato nell’arco di un secolo a una drastica riduzione dell’orario di lavoro, ampliando così il tempo libero da dedicare allo svago personale. Oggi – grazie all’imponente sviluppo tecnologico – sarebbe teoricamente possibile “liberarsi dal lavoro”, almeno per una parte consistente dell’umanità: ciò, tuttavia, renderebbe indispensabili – secondo De Masi – l’introduzione del “salario universale” a tutela dei disoccupati in costante aumento e l’edificazione di una società meno competitiva e più solidale. Questo salto verso il “regno della libertà” – per il momento – è reso impossibile dal predominio globale del capitalismo neoliberista, che continua invece a esigere «il lavoro senza fine, la precarietà, l’isolamento, lo stress, la paura e la certezza di perdere rapidamente il lavoro» (Bernard Maris, Antimanuale di economia, Tropea).
Le immagini: oltre alla copertina, a uso gratuito da pixabay.com.
Giuseppe Licandro
(LucidaMente 3000, anno XVII, n. 202, ottobre 2022)


















Sono queste le questioni cruciali, altro che le battaglie ideologiche e l’antifascismo di maniera dei radical chic.